Questo articolo fa uso del Simulatore 3D
Se si dovessero riscontrare problemi nel caricamento dell’applet, scaricare manualmente l’ultima versione di JRE (Java Runtime Environment) all’indirizzo: http://www.java.com/it/download/index.jsp
Questa sonda, progettata dalla John Hopkins University e gestita dalla NASA, ha una sigla (NEAR, che come noto in inglese significa “vicino”) particolare e ricorsiva: NEAR è l’abbreviazione delle parole “$Near$ Earth Asteroid Rendezvous” (Rendezvous di un asteroide vicino alla Terra) e dunque all’interno della sigla contiene in pratica la sigla stessa. Inoltre c’è da dire che l’asteroide obiettivo della missione (433 Eros) è a sua volta ben noto come rappresentante dei cosiddetti NEA ($Near$ Earth Asteroids).
Ma facciamo un po’ d’ordine con tutti questi “NEI”… 😉
Si tratta di circa 3000 asteroidi che hanno un’orbita molto vicina a quella della Terra e tra questi c’è per l’appunto Eros, il più grande del gruppo, scoperto nel 1898, con un’orbita ellittica che va da un minimo di 1.13 UA (1 UA è la distanza media della Terra dal Sole) ad un massimo di 1.78 UA, rispettivamente al perielio e all’afelio della sua orbita.
Questi valori rimarrebbero abbastanza aridi se non ci fosse la possibilità di visualizzarli: noi abbiamo il nostro simulatore 3D che ci permetterà come sempre di vedere dove era situato l’asteroide Eros nel periodo in cui la sonda NEAR ha effettuato il suo volo.
Lanciamo perciò il simulatore 3D e seguiamo la sonda, non più grande di un’automobile (foto), a partire dalla data suo lancio, avvenuto il 17 febbraio 1996. I più attenti noteranno che nel simulatore la traccia della sonda inizia solo il 31 maggio: non so per quale motivo, ma i dati che il JPL fornisce per la NEAR iniziano solo a quella data e perciò per qualche mese si vedono solamente i pianeti e altri oggetti, mentre poi all’improvviso comparirà dal nulla anche la sonda…
Scopo dunque della missione era l’atterraggio sull’asteroide Eros, dopo averlo rincorso negli spazi siderali: lanciata da un razzo (il Delta-2) che ha il record di essere il più piccolo mai utilizzato per questo scopo, anche la sonda NEAR ha sfruttato il Gravity Assist (GA) da parte della Terra per modificare la propria velocità e posizionarsi in un’orbita più favorevole per raggiungere il suo $obiettivo$.
Subito dopo il lancio, il 24 marzo 1996, la NEAR aveva puntato i suoi strumenti verso la cometa Hyakutake, appena scoperta, della quale ha tratto questa immagine. Nel simulatore ho aggiunto pure la cometa per poterne vedere la posizione al momento della foto, anche se non esistono dati orbitali della NEAR e quindi si può solo intuire la geometria della ripresa fotografica.
Come di consueto la traiettoria prescelta per la sonda prevedeva anche l’incontro ravvicinato con un altro asteroide: ecco che dunque dopo un anno e quattro mesi dal lancio ed in rotta verso il suo GA, la sonda NEAR ha incrociato l’orbita dell’asteroide 253 Mathilda, che ha raggiunto ad una minima distanza di appena 1212km il 27 giugno 1997 (foto). Proprio durante l’avvicinamento ed il successivo allontanamento dall’asteroide, la NEAR ha scattato una serie di foto, che poi i tecnici della NASA hanno raccolto in un breve filmato molto simpatico.
Il tempo scorre inesorabile: dal simulatore vediamo che dopo l’incontro con Mathilda la sonda si dirige verso la Terra, che raggiungerà a quasi due anni dal lancio, il 23 gennaio 1998: è facile vedere che la sonda ha effettuato praticamente un’orbita intera mentre la Terra ne ha compiute due quasi complete. Il rendezvous con GA avvenne con un passaggio ad una distanza minima dalla Terra di 540km e durante questo flyby la sonda ha effettuato una bellissima ripresa della Terra e della Luna. Le immagini mostrano chiaramente l’emisfero australe: si riconosce bene la bianchissima Antartide, mentre i vari oceani, che circondano il continente dei ghiacci, erano ricoperti qua e là da bizzarri strati di nuvole.
Grazie quindi alla spinta gravitazionale della Terra, la sonda NEAR ha acquistato una velocità tale da modificare la sua orbita e permetterle di raggiungere (almeno nella teoria) l’$obiettivo$. Il primo aprile 1998, praticamente a metà strada tra la Terra e Eros, la sonda ha battuto un record che resisteva dal 1992 a favore della sonda Galileo: in pratica la NEAR è stata osservata da un astrofilo del Nuovo Galles del Sud (Australia), allorché si trovava alla ragguardevole distanza di 33 milioni e 650mila km dalla Terra. Pensate che il record precedente era di “appena” 8 milioni di km, quattro volte di meno! In questo modo la sonda NEAR è il manufatto umano che è stato visto dalla maggiore distanza in assoluto, ovviamente con strumenti ottici.
Non tutte le ciambelle riescono con il buco
Abbiamo dunque visto che ora la sonda ha cambiato la propria orbita, molto meno allungata della precedente per poter raggiungere il suo bersaglio in breve tempo. Ma questa volta non tutto è andato liscio come l’olio.
Se seguiamo l’orbita tracciata nel simulatore, possiamo vedere che la sonda si avvicinava sempre di più ad Eros e già a partire da dicembre del 1998 il puntino si posizionava stabilmente a fianco all’asteroide, fino alla fine della missione: è questo un effetto dovuto all’inevitabile approssimazione nei calcoli del programma.
Ma nella realtà la sonda, a causa di un guasto, rimaneva, sì, sempre nei paraggi dell’asteroide, però non così vicino da poter proseguire positivamente la missione affidatale.
Analizziamo in dettaglio che cosa è successo il 20 dicembre 1998… Semplice! La sonda non è riuscita a frenare, insomma ha tirato dritto, mancando l’$obiettivo$ e sorpassandolo! A causa di un guasto la sonda è infatti rimasta spenta, in blackout, per ben 27 ore, proprio in un momento cruciale della missione: se si fosse spenta durante il viaggio, magari tutto sarebbe proseguito senza problemi. Invece spegnersi sul più bello, quando dovevano essere accesi i motori per rallentarla, poteva compromettere seriamente l’esito della missione stessa, come già era capitato altre volte ad altre colleghe di viaggio.
Ancora una volta però i tecnici sono stati molto bravi, oltreché decisamente fortunati: quando stavano quasi per abbandonare la missione sono riusciti a escogitare una manovra correttiva. Ma andiamo per ordine…
Nonostante la folle corsa, la sonda aveva iniziato comunque ad inviare una lunga serie di foto di Eros (1 e 2): già da queste foto l’asteroide mostrava una forma alquanto strana, praticamente un incrocio tra una patata ed un’arachide, ricco di crateri e dotato di un avvallamento a forma di sella da cavallo: una roccia non molto grande, lunga 34km e larga poco più di 11km.
Ma torniamo ai tecnici del centro di controllo: hanno subito iniziato a lavorare febbrilmente notte e giorno per cercare di far ritornare sui suoi passi la sonda. I tentativi in merito, come detto, sono falliti per più di un giorno, fatto questo che l’allontanava sempre più dal bersaglio: l’unico fattore positivo per i tecnici era dato dal fatto che la sonda non era molto lontana dalla terra per cui i messaggi da e verso la sonda richiedevano in media solo una quindicina di minuti per arrivare a destinazione.
Finalmente all’inizio di gennaio la sonda iniziò a rispondere ai comandi e venne deviata per tornare indietro sui suoi passi: le ci vorrà quasi un anno per poter ritornare innanzitutto vicino all’asteroide e poi entrare in orbita.
In totale la sonda effettuerà ben 230 orbite, prima di percorrere il suo ultimo tratto che la porterà ad impattare, con una via di mezzo tra uno schianto ed un atterraggio morbido, visto che non aveva zampette adatte a poter atterrare (tipo un LEM sulla Luna).
Era il 12 febbraio 2001: in realtà i tecnici della NASA, nonostante tutti i problemi che avevano dovuto affrontare, contavano di effettuare l’atterraggio su Eros (il Dio dell’Amore) proprio il giorno dedicato all’Amore, S.Valentino, il 14 febbraio.
Credo che nessuno si sia scandalizzato per questi 2 giorni d’anticipo, visto come s’erano messe le cose: comunque sono stati già bravissimi a prendere per i capelli una situazione destinata al fallimento.
Analizziamo da vicino la nuova traiettoria della sonda
A differenza di altri articoli precedenti in cui i dati da fornire al simulatore erano già pronti (generati dal JPL), stavolta ho dovuto rielaborare i dati della sonda a colpi di Excel per poter dunque seguire da vicino quello che è successo nei pressi dell’asteroide, a partire dalla data del primo incontro mancato, sino alla fine della missione.
Ora viene la parte divertente: per seguire le mille e mille evoluzioni della sonda “trattenuta per i capelli”, non basterà cliccare il tasto “play”, dato che la situazione evolve dinamicamente e c’è il rischio di non vedere nulla, perchè magari avviene troppo in fretta. Bisognerà infatti cambiare molto spesso lo zoom ed il passo.
Devo confessare che non è molto fedele il disegno dell’asteroide al centro del diagramma: è una piccola sfera, mentre in realtà sappiamo che ha una forma particolarmente strana. Chiudiamo dunque un occhio, pensando che invece le orbite percorse dalla sonda intorno ad Eros sono senz’altro corrette.
Lanciamo ora il simulatore 3D ridotto e vediamo di capire come sono andate le cose.
Partiamo con un valore di zoom pari ad 1 ed uno step di 2 ore: il puntino al centro è Eros e dando il via alla simulazione la sonda arriva subito alla vista (provenendo da “ore una”). Vediamo che prosegue in diagonale sfrecciando davanti al puntino senza nessuna intenzione di frenare! Intorno al 23 dicembre è, sì, puntuale al rendezvous, ma con un bel po’ di velocità in esubero…
Passano le ore e i giorni ed il 5 gennaio vediamo che la sonda subisce una brusca sterzata: fermiamoci qui per goderci poi in santa pace la lenta orbita di riavvicinamento all’asteroide, che durerà quasi un anno! Ho parlato di brusca sterzata: scordatevi però le manovre di frenata da parte di intrepidi piloti, da Han Solo a Luke Skywalker, da Kirk a Spock oppure quelle manovre che consentono ad astronavi supermaneggevoli di librarsi tra migliaia di asteroidi, roccette e detriti vari, schivandoli tutti! Sono tutte manovre, queste, ad altissimo costo energetico! Frenare una navetta che corre ad alta velocità non è uno scherzo: ma la fantascienza non sarebbe tale!
La realtà invece è apparentemente più deludente: quasi un anno per tornare indietro! Ma mica c’era un pilota dentro la NEAR! C’erano invece quei poveracci di tecnici della NASA che hanno fatto davvero i salti moltali per salvare capra e cavolo.
Riprendiamo la simulazione aumentando ora lo zoom a 3 e lo step a 1 day: visto che bella orbita? Arrivati a circa il 25 novembre 1999, fermiamoci di nuovo, aumentiamo lo zoom a 50 e facciamo ripartire la simulazione sempre con lo step ad 1 giorno.
Arrivati al 5 febbraio 2000 fermiamo il tutto, aumentiamo lo zoom a 1000 e abbassiamo lo step a 6 ore.
Vedremo la sonda superare di poco Eros il 16 febbraio: fermiamoci, mettiamo lo zoom a circa 5000 e godiamoci le più di 200 orbite della NEAR attorno a Eros. Ridendo e scherzando passerà un altro anno! Possiamo anche mettere la “tail len” a 30 steps, così non vedremo un gomitolo di orbite.
Verso giugno 2000 potete zoomare fino a 8000 e abbassare lo step a 2 ore, così vedrete ancora meglio le orbite: ovviamente potete spostarvi con la barra orizzontale o quella verticale (oppure con il mouse, con il click & drag), per vedere la scena da prospettive differenti, ricordando di non fare troppo affidamento sulla sferetta che vorrebbe rappresentare Eros, contro la quale la sonda va a sbattere a più non posso…
Man mano che la sonda percorre le sue 230 orbite, vediamo ogni tanto un sobbalzo seguito da nuove orbite, disposte su altri piani orbitali: si tratta di manovre correttive da parte degli infaticabili tecnici della NASA. Ognuno di questi cambiamenti di orbita era stato effettuato per avvicinare sempre di più la sonda all’$obiettivo$ finale, avendo nel frattempo la possibilità di studiare sempre più in dettaglio l’asteroide.
Quasi senza accorgerci, arriviamo al 12 febbraio 2001, allorché la sonda “sparisce”: sappiamo che possiamo tornare indietro nella simulazione, per vederla riapparire e poi atterrare “sul vuoto” ed infine scomparire di nuovo… solo perchè dopo l’atterraggio mancano i dati orbitali. Siamo arrivati dunque all’impatto finale!
Fotografando Eros
Iniziamo questa rapida carrellata di foto con dei meravigliosi primi piani ripresi a giugno del 2000, a settembre 2000 e a gennaio 2001 (1, 2, 3, 4 e 5).
Vediamo ora un paio di animazioni: la prima, quando ancora la sonda era lontana mentre la seconda rappresenta un’inquietante Eros che ci rotola a fianco! Vi sono poi delle foto composite (cioè un fotomosaico di più riprese) come questa, dove vediamo una creativa fotocomposizione a forma di serpente che fa vedere Eros man mano che si avvicinava (ruotando intorno al proprio asse), e come questa, dove vediamo una rotazione quasi completa del nostro asteroide.
Sappiamo che la sonda ha effettuato un atterraggio sulla superficie: ecco dunque le ultimissime foto scattate dalla NEAR a distanze decrescenti: a 1150m, a 700m, a 250m ed infine qualche istante prima dell’impatto, tanto è vero che la foto presenta una parte incompleta. Dicevo prima che l’atterraggio è stato quasi morbido: la sonda ha impattatto sì, ma con una velocità di circa 6 km/h, ed ha continuato ad inviare dati per un paio di settimane, fino al 28 febbraio 2001, quando ha inviato i suoi ultimi messaggi. Un trionfo comunque, sia per la sonda che per i tecnici della NASA!
Qualche informazione aggiuntiva sull’asteroide
Parliamo di attrazione gravitazionale: dato che l’asteroide è piccolo, la sua gravità è altrettanto bassa, ma abbastanza da aver mantenuto prima la sonda in orbita e sufficiente poi a trattenerla sulla sua superficie, al termine della missione.
Ma una persona che avesse la possibilità e la fortuna di recarsi su Eros, come si troverebbe? Sentirebbe una differente gravità in funzione del punto dove si trova, vista la conformazione alquanto strana dell’asteroide: un uomo di 90 chili peserebbe meno di un chilo ed un giocatore di basket, con un balzo di meno di un metro potrebbe saltare fino ad un miglio di altezza, con il rischio di entrare in orbita…
E la temperatura? La NEAR non aveva a bordo strumentazione adatta alla misura della temperatura, ma comunque gli scienziati l’hanno stimata in base alla distanza di Eros dal Sole ed alle proprietà termiche misurate da Terra con i telescopi: questi calcoli dicono che la temperatura diurna di Eros, nel lato esposto al Sole, è di circa 100°C, mentre la temperatura notturna si avvicina a -150°C.
Altre notizie riguardano il fatto che la sonda ha ricavato una montagna di dati sull’asteroide, (dicono 10 volte di più di quanto pianificato), completando un profilo scientifico veramente dettagliato di Eros, una roccia solida, relitto primitivo dell’epoca della formazione del Sistema Solare.
La sonda ha scattato qualcosa come 160.000 foto di questo incredibile oggetto: i tecnici instancabili hanno contato sulla sua superficie più di centomila crateri e circa un milione di rocce grandi come una casa. Hanno riscontrato infine, com’era lecito attendersi, uno strato superficiale di detriti risultanti da una lunga teoria di impatti.
Concludo questa analisi delle peripezie della gloriosa sonda NEAR, segnalando che a marzo del 2000 la sonda era stata ribattezzata “NEAR Shoemaker” in onore del valentissimo astronomo, deceduto oramai da circa tre anni, che aveva dedicato la vita allo studio delle comete e degli asteroidi.

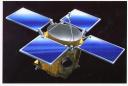
Guardando gli impatti più grandi che hanno interessato l’asteroide mi viene spontaneo farmi alcune domande: Come ha fatto a non frantumarsi? Potrebbe essere che gli impatti subiti siano avvenuti con l’oggetto che faceva parte di un corpo più grande e poi catturato sull’orbita attuale? Anche perchè l’orbita non è che sia particolarmente eccentrica…
Saluti
Che viaggio
@SANDRO
aspettando magari il parere dell’espertissimo enzo, secondo me potrebbe essere che quello che vediamo di Eros sia proprio quello che è rimasto dalla frantumazione oppure dalla ricomposizione di più parti…
@Matteo
sì, una vera odissea!! 😮
@sandro,
Eros, come tutti i suoi fratellini che viaggiano su orbite in grado di intersecare quelle dei pianeti interni, sono nati nella zona della fascia principale. Come TUTTI gli asteroidi con dimensioni inferiori a poche centinaia di chilometri (quindi quasi tutti) sono frammenti di urti catastrofici tra loro. Normalmente questi frammenti restano nella zona di origine, dato che gli urti (pur distruggendoli) non hanno l’energia sufficiente a mandarli direttamente su orbite significativamente diverse da quelle originarie. Alcuni però, vicino alle zone “proibite” in risonanza di moto medio con Giove, possono finirgli dentro. A quel punto il loro destino è segnato e cominciano un viaggio che in pochi milioni di anni li costringe a cambiare radicalmente l’orbita fino a farli diventare NEA. Quindi sono già di per sè frammenti, ma -ovviamente- continueranno a essere colpiti da oggetti più piccoli e ne conserveranno i segni. A volte possono anche essere nuovamente distrutti, ma l’autogravitazione è sufficiente a rimettere insieme i frammenti. Questo è probabilmente il caso di eros (e di molti NEA) dalla struttura composta di enormi macigni tenuti insieme dalla gravitazione mutua e coperti dalla polvere (megaregolite) che si crea nei micro urti successivi. I crateri che vediamo oggi su Eros sono quindi recenti, ma non tali da aver distrutto l’oggetto celeste. Prima o poi però anche Eros avrà una fine segnata. O finirà dentro al Sole, o finirà contro un pianeta, o sarà distrutto senza possibilità di ricomporre un oggetto unico, o-infine- sarà scacciato dal Sistema Solare. Non si può prevedere, in quanto -come tutti gli altri del suo tipo- è su un’orbita caotica che può cambiare notevolmente a causa dei passaggi ravvicinati con i pianeti terrestri. Se vuoi saperne di più, puoi leggere l’articolo
http://www.astronomia.com/2008/04/02/dalla-fascia-degli-asteroidi-alla-terra-un-viaggio-entusiasmante/
Per il momento Eros non sembra aver problemi di impatto, ma domani…chissà! e allora poveri noi….
Grazie Enzo, sei sato molto chiaro. Ma visto che mi hai dato tutte queste belle informazioni, vorrei aggiungere una ulteriore riflessione personale alla cosa. Se non ho capito male hai evidenziato il fatto probabile che Eros si sia ricompattato con l’autogravitazione a seguito di impatti precedenti. Francamente ho dei dubbi che sotto la megaregolite ci siano dei massi collegati fra loro. A me sinceramente sembra più un pezzo unico. Per carità, probabilmente mi sbaglio, ma può darsi che la regolite ci tragga in inganno…..
@sandro,
la megaregolite può essere molto spessa (decine di centimetri) e copre tutto. Ciò che è decisivo è la misura della densità. per eros si ha un valore di circa 2.4 g/cm3 ed è al limite… Molto più sicuri di avere un insieme di frammenti tenuti insieme dall’autogravità lo siamo per Mathilde e Itokawa, la cui bassa densità non è compatibile con quella del materiale superficiale. Questo vuol dire che il volume interno ha dei veri e propri buchi… Ovviamente l’aspetto esterno non lascerà mai tradire ciò che vi è all’interno….
…come al solito non mi si apre il simulatore 3D 😥
Scusate l’ignoranza ma.. un “sasso” di 34 x 11 km di che autogravitazione dispone? ..sarà un fattore millesimale.. Riuscite a darmi un termine di paragone?
@U-olter,
non è difficile fare i conti, ma non è tanto importante il valore. In un urto più o meno catastrofico i frammenti escono con un ventaglio di velocità che hanno un picco proprio intorno alla velocità di fuga dall’oggetto. Molti quindi ricadono uno sull’altro formando l’ammasso di sassi (rubble-pile, in inglese). Altri scaperanno. per oggeti più grandi, parte dei frammenti rimangono in qualche modo legati all’oggetto più grande e formano una famiglia, come descritto qui:
http://www.astronomia.com/2008/04/02/dalla-fascia-degli-$asteroidi$-alla-terra-un-viaggio-entusiasmante/
le foto dei due asteroidi ricordano molto i due satelliti di marte 🙄
@Silvia
Ti viene restituito qualche messaggio di errore?
Prova comunque a reinstallare il JRE
Caspita la cometa Hyakutake è passata molto vicina, prima a Venere e poi alla Terra… Il bello che non si sapeva neppure l’esistenza… Mi fa pensare che da quel momento sono partiti tutti i programmi per i NEA? 🙂
Bellissimo articolo